C’è qualcosa che non torna nell’azione di Carlo Maria Viganò. E non è solo il merito delle sue accuse a Francesco o il suo pensiero teologico-politico, pericolosamente incline alla confusione tra spirituale e temporale (vedi le discutibili analogie tra deep state e deep church).
Ciò che mi ha colpito in negativo, fin da subito, è il metodo che si è scelto: un dossier scandalistico fatto di intrecci tra verità e finzione (un obbligo per tutte le operazioni di questo genere, che risultano tanto più credibili quanto più sono verosimili) e dato in pasto alla stampa globale. Il tutto, naturalmente, in nome di una verità da difendere a ogni prezzo tanto da richiedere la “messa in stato di accusa” del papa.
Se non fosse che i processi sommari per via mediatica notoriamente non garantiscono giustizia e accertamento della verità, ma solo la gogna e il linciaggio morale dell’accusato. Si fatica a intravedere il profilo di Cristo dietro a quello del capitano Lynch… Chi sceglie questa strada – il tribunale del popolo mediatico – non ha interesse a far trionfare “la” verità ma solo la “sua” verità.
Beninteso: non ritengo affatto che l’amore e la fedeltà escludano lo spirito critico.
In uno dei (tanti) meravigliosi passi di Ortodossia, Chesterton smentisce il luogo comune dell’amore cieco. È giusto al contrario, afferma il grande apologista britannico: il vero amore è tutt’altro che cieco; non si accontenta di accogliere l’oggetto del suo amore: vuole trasformarlo, perfezionarlo, portarlo a compimento, aiutarlo a realizzare le sue potenzialità. Così le donne, che difendono a spada tratta i loro uomini nelle piccole e nelle grandi cose, sono estremamente critiche con loro in privato e ne conoscono a menadito tutti i difetti, piccoli e grandi che siano. Il vero amore sa dunque essere critico, e sbaglia chi confonde la fedeltà col silenzio e la remissività (altrimenti in nome di cosa andrebbe condannata l’omertà?).
Ma la critica dell’amore ricerca pur sempre il bene del suo amato e come c’è una critica che costruisce (la critica dell’amore, appunto) c’è anche una critica che distrugge – anche se si ammanta delle migliori intenzioni (la difesa della verità, tipicamente). Come sempre, evangelicamente parlando, la bontà di un metodo si giudica dai frutti. E basta bazzicare i social per constatare l’effetto prodotto da queste operazioni scandalistiche: la proliferazione della rabbia, l’inasprimento degli animi, la divisione in frazioni litigiose che dibattono con asprezza senza mai comunicare tra loro. È l’unità della Chiesa che è stata intaccata.
La correzione fraterna passa per altre vie. San Tommaso d’Aquino, che dedica un’intera quaestio della Somma teologica (II-II, q. 33) al tema della correzione fraterna, sostiene che essa può anche essere sospesa in attesa di un tempo più opportuno per esercitarla o per timore che il peccatore si indurisca nella sua condotta e, dunque, perfino peggiori. E guai quando la correzione è ispirata da un desiderio di rivalsa o dal pensiero di dover portare a casa dei risultati (la “conversione” del peccatore magari, come se essa fosse il prodotto dei nostri sforzi e non della grazia divina). I santi sapevano bene che un cattivo metodo può vanificare la migliore delle intenzioni.
Il fatto è che la Chiesa non è semplicemente una “causa” o una “idea” da abbracciare con fanatica convinzione da una “società di giusti”. Se così fosse, non vi sarebbe grande differenza tra la chiesa e una qualunque società di pensiero, tra la fede della chiesa e una qualunque ideologia. E i cattolici sarebbero indistinguibili da una frangia lunatica di ringhiosi estremisti.
L’estremista, lo ricordo, è l’uomo di un’idea; soggiace a quella che Hannah Arendt usava definire la tirannia della logicità. Ogni pensiero estremo assolutizza un’idea, o un pugno di idee centrali, a cui si vota in maniera incondizionata. La massima condivisa da ogni estremista è “il fine ideale giustifica i mezzi”. Nulla conta più della logica interna del sistema ideologico, elevato a (tirannico) sistema di spiegazione universale. Tutti gli altri valori, inclusi l’amicizia, la lealtà, il rispetto della vita e della dignità personale, devono passare in secondo piano.
È un pensiero che troviamo espresso alla perfezione nel Catechismo del rivoluzionario – attribuito talora a Bakunin, ma più probabilmente opera di Sergej Nečaev. Basta leggere alcuni passaggi:
«Il rivoluzionario è un uomo perduto in partenza. Non ha interessi propri, affari privati, sentimenti, legami personali, proprietà, non ha neppure un nome. Un unico interesse lo assorbe e ne esclude ogni altro, un unico pensiero, un’unica passione: la rivoluzione. […] Per lui è morale tutto ciò che contribuisce al trionfo della rivoluzione; immorale e criminale tutto ciò che l’ostacola. […] Duro verso se stesso, deve essere duro anche verso gli altri. Tutti i sentimenti teneri che rendono effeminati, come i legami di parentela, l’amicizia, l’amore, la gratitudine, lo stesso onore, devono essere soffocati in lui dall’unica, fredda passione per la causa rivoluzionaria. […] Il rivoluzionario può essere amico solo di chi ha dato prova di uno zelo rivoluzionario analogo al proprio. La possibilità di stabilire rapporti di amicizia, di intimità e di cameratismo è determinata esclusivamente dal grado di utilità della relazione ai fini della rivoluzione distruttrice pianificata». (Michael Confino, Il catechismo del rivoluzionario. Bakunin e l’affare Nečaev, Adelphi, Milano 2014, pp. 125-127)
Qui in nuce c’è già tutta la violenza del fanatismo ideologico: il suo settarismo feroce, il suo manicheismo (i “buoni” si contano solo fra le nostre file, all’infuori non vi è che tenebra), l’insofferenza per ogni forma di misericordia. Il rivoluzionario – questo estremista per antonomasia – è un «uomo perduto in partenza» perché ha rinunciato a ogni senso di umanità, a ogni vincolo carnale, a ogni appartenenza che non sia collegata alla sua idea astratta. È un deraciné, uno sradicato. O meglio, un disincarnato.
Non bisogna avere timore di dirlo: abbracciare una simile metafisica della separazione, teorizzare l’inimicizia tra gli uomini è incompatibile con la carità cristiana e il dogma dell’incarnazione.
Lo spiega, in una bellissima opera (Cattolicismo, gli aspetti sociali del dogma), il padre Henri de Lubac. La liberazione apportata dall’amore cristiano, mostra de Lubac, libera l’uomo dalla guerra contro Dio iniziata col peccato. Ma non solo: lo riconcilia anche coi suoi fratelli in umanità. Come l’inimicizia tra Dio e gli uomini aveva portato alla divisione degli uomini tra di loro, così la riconciliazione operata nel cuore umano dalla grazia divina conduce alla mutua riconciliazione tra gli uomini. Così la liberazione interiore, spirituale, diventa liberazione esteriore. L’amore cristiano uccide l’odio, porta la pace, affranca gli uomini dall’inimicizia che li contrappone gli uni agli altri e istilla in loro un senso di fraternità.
Di questa riconciliazione parla Paolo, quando afferma che «in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia, annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia» (Ef. 2, 13-16).
Per questo ogni schermaglia all’interno della Chiesa deve avere cura di non spezzare il vincolo dell’amore. La Chiesa non è semplicemente una “causa” o una “verità” da difendere. È prima di tutto, per dirla col Pascal dei Pensieri, un «corpo pieno di membra pensanti» che, «mirando soltanto al bene del corpo, fanno insieme il proprio bene» (550-551).
Occorre fare attenzione, perché, avverte sempre Pascal, «ci si può fare un idolo persino della verità, perché la verità, scissa dalla carità, non è Dio: ne è soltanto l’immagine, un idolo che non dobbiamo né amare né adorare» (541).
La fede della Chiesa non è una “dottrina infallibile” monopolizzata da un “partito di puri”, ma una trasmissione affidata a una comunità vivente. Pertanto, come ha scritto Joseph Ratzinger in Natura e compito della teologia, «più importante della nozione di «infallibilità» è quella di auctoritas», uno dei presupposti irrinunciabili di qualsiasi forma di vita comunitaria e che, secondo il grande classicista Theodor Mommsen, «è più di un consiglio e meno di un ordine».
L’autorità è qualcosa di ben diverso dal potere, tanto che possiamo avere sia un potere senza autorità (l’autoritarismo del “capetto”) che un’autorità senza potere (il prestigio del “vecchio saggio”). L’autorità si distingue anche dalla forza, che essa permette di evitare, e dall’argomentazione razionale, che essa supera. Non ha bisogno né di imporsi né di giustificarsi. Senza autorità, avremmo solo la caserma o un cenacolo di intellettuali, ma non la società.
Anche la Chiesa è una società, ancorché sui generis, e necessita dell’autorità. E il polemismo a oltranza, la contestazione perpetua del papa non fanno che minare il principio di autorità interno della Chiesa. È una critica che delegittima, che si confonde con l’ostruzionismo.
La comunione con Pietro non è un fatto accessorio per chi, come i cattolici, crede a un Dio incarnato. Radunarsi attorno a una roccia di carne – e non aderire soltanto a un patrimonio di idee astratte – impedisce loro di trasformarsi in una setta ideologizzata. Sotto questo punto di vista ha ragione chi, come Fabrice Hadjadj, considera «il sommo pontefice la massima punta dell’Incarnazione, il contrappeso della materia a qualsiasi ideologia, ciò che spinge i fedeli a raccogliersi non soltanto intorno a una dottrina, ma anche intorno a un uomo con un volto e una storia, perché l’amore di Dio è indissociabile dall’amore del prossimo, e perché la voce di Cristo maestro deve ancora essere udita nella voce di questo magistrale prossimo — il Santo Padre».






































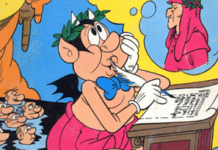






Prima di ogni giudizio occorre bene osservare e seguire entrambi le parti coinvolte. Non si può, né si deve, supportare una parte poiché si presuppone che, per la posizione ricoperta, sia inviolabile. Anche un Papa fa errori, pensando invece che stia facendo del bene alla Chiesa. In questo caso è giusto che sia redarguito nell’amore di Cristo, come lo fu anche Pietro a suo tempo.
Non si può costantemente guardare fuori dalla Chiesa, dimenticando i fratelli in difficoltà nella stessa, il ruolo del Papa deve essere primariamente questo, unire la Chiesa, come prima colonna e come vicario di Cristo.
In ogni caso l’arma più potente resta la Preghiera, Papa Francesco ne ha davvero bisogno, come anche mons. Viganò e tutti i servi di Cristo, a maggior ragione in questi tempi bui.
Pax et bonum.