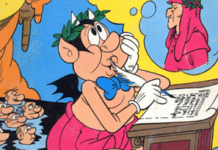Nel ‘68 la parola magica è stata “liberazione”. Ma, da allora, la libertà, lungi dall’essere “liberata”, è ridotta a fare tutto ciò che sta in un determinato recinto intorno all’ombelico.
Non siamo mai usciti dal ’68.
Quella eliminazione di ogni vincolo alla “liberazione” dell’uomo, iniziata con i primi movimenti studenteschi alla fine degli anni ’60 continua la sua marcia ancora oggi.
Ma, se dovessimo dirlo in una parola, “da che cosa” volevano “liberarsi” i sessantottini? E che cosa cercavano, alla fin fine?
A ben guardare, i sessantottini hanno eliminato alla radice il problema dei problemi dell’uomo, quello poeticamente espresso da Leopardi nel Canto del pastore errante: “Dimmi: perché giacendo a bell’agio, ozioso, s’appaga ogni animale; me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?”
Ecco, nel ’68 l’uomo ha preteso di farsi “animale”, nel senso più neutrale e meno offensivo del termine. Di stare tranquillo e di eliminare dalla scena ogni distrazione dal mangime del “solo pane”, dal gregge della “società perfetta” (quella in cui a tutti gli animali sia data la giusta razione), dall’istinto di riproduzione (la libertà sessuale) elevato a ragione di vita, e via belando. Per assecondare meglio la beluinità, l’uomo si è dotato anche di apposita erba, da fumare e non da brucare, il cui effetto era (ed è) comunque quello di produrre l'”appagamento” facile della pecora leopardiana (l’unica differenza aggravante è che la bestia non si sente particolarmente trasgressiva e “di tendenza” mentre s’impecorisce, invece l’uomo sì).
Non che tutto questo non esistesse anche prima del ’68, ma, certamente, in quel fatidico anno è successo che quest’ansia di “auto-riduzione” si sia improvvisamente trasferita prima ai giovani studenti e poi alle masse, diventando opinione comune, anzi “pensiero unico”.
Simbolo di questo nuovo “sentire comune” imposto ad arte è lo stravolgimento del concetto di “libertà”. Questa si trasferisce dall'”umano” al “ventre” o, al più, al “costume”. Non ha più niente a che fare con la grandezza del sentimento umano, anzi è tanto più esaltata quanto più dà spazio ad un’umana piccolezza. Fu durante il ’68, infatti, che cominciò ad affermarsi il significato che ancora oggi si intende di “libertà”: quella di fare tutto ciò che sta in un determinato recinto intorno all’ombelico. Così la libertà dell’uomo, il centro della sua dignità, si riduce a “libertà sessuale”, “di divorziare”, “di abortire”, “di sperimentare “trasgressioni”. Il tutto sotto la forma “eroica” della ribellione all’autorità. Se facciamo per un attimo i satanisti, è difficile immaginare una luciferina pentola migliore di questa: la perdita beluina di sé e della propria autentica libertà, accompagnata da un senso di prometeica “liberazione” dalle catene. Insomma, schiavi e felici di esserlo, si direbbe. Ma manca un dettaglio: la pecora è perfettamente soddisfatta in uno stato pecorile, mentre l’uomo – che lo sappia o meno – no. Così, il vero sostrato comune a questa paccottiglia di riduzione umana diventa uno solo: “la negazione” del mondo, dell’uomo e, alla fine, di sé (come dimostra l’esito del terrorismo e non solo).
A meno che l’Io non trovi la forza di commuoversi davanti ad un volto nazareno che lo implora di credere in lui il significato della propria immensa libertà.