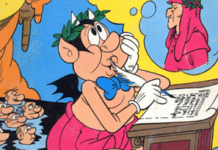Come tanti altri, in questo momento di epidemia ho deciso di riprendere in mano La peste di Albert Camus. In questo romanzo del 1947, il suo primo grande successo letterario, Camus racconta i fatti legati a una violenta epidemia di peste nella città algerina (ma ancora sotto la dominazione francese) di Orano.
La quotidianità di Orano prima dell’epidemia scorre via all’incirca come quella dei nostri giorni: una vita frenetica, dove i cittadini lavorano molto e pensano ad arricchirsi, in cui le relazioni personali si caratterizzano per una totale insignificanza affettiva («a Orano, come altrove, in mancanza di tempo e di riflessione, si è costretti ad amarsi senza saperlo») tanto che agli amanti, quando non «si divorano rapidamente in quello che si chiama atto d’amore», non resta che impegnarsi «in una lunga abitudine a due».
Unica religione a Orano è una religione della felicità, una felicità personale e terrena fatta di momenti, che impone di consumare la vita. Tutto questo produce aridità esistenziale e indifferenza nei riguardi del prossimo, in particolare verso i malati. La religione della felicità ha il culto della performance. Pertanto lo stile di vita di Orano «richiede la buona salute», esige efficienza, prontezza, risolutezza. E dunque «un malato vi si trova proprio solo».
Anche il francese Bernard Rieux, protagonista e cronista del racconto, aderisce a questa religione della felicità. Rieux è un medico. È un uomo concreto, un agnostico che non si fa illusioni e lotta contro il male pur sapendo che ogni vittoria non è che un successo parziale. La felicità, quaggiù sulla terra, è sempre minacciata. La peste cesserà prima o poi; ma il morbo è destinato a ripresentarsi. Altre malattie poi incombono; anche quei mattatoi che sono le guerre ricominceranno sempre; gli innocenti continueranno a soffrire e la cattiveria dell’uomo proseguirà senza sosta la sua corsa maligna. L’unica cosa da fare è ricominciare sempre e lottare contro la sventura, come Sisifo che incessantemente ricomincia sempre da capo la sua scalata, spingendo la pietra verso una cima che non raggiungerà mai. Il dottor Rieux è un “Sisifo infelice”, un “santo senza Dio”; uno di quegli uomini, i migliori, che accettano di sacrificare la propria personale felicità per proteggere e promuovere la felicità altrui. È un martire ateo della solidarietà che si batte per rendere “Sisifo felice”.
Nel racconto di Camus c’è anche un altro “santo senza Dio”: Jean Tarrou, figlio di un grande penalista francese. È un personaggio dall’aria vagamente misteriosa che annota la cronaca della pestilenza nel suo taccuino. Il mistero di Tarrou si svela nel corso degli eventi, palesando in lui il reduce di un dramma esistenziale. Un tempo, racconta egli stesso, stimava immensamente il padre. Lo amava, lo ammirava. Ma il sentimento di venerazione svanisce quando il genitore lo invita ad assistere ad una sua causa in tribunale nella speranza che il figlio, conquistato dalla sua oratoria e dalla sua perizia, finisca per abbracciare la sua stessa carriera.
Ma accade esattamente l’opposto di quanto si augurava. La sua requisitoria sconvolge il figlio – che lo descrive così: «Trasformato dalla toga rossa, né bonario né affettuoso, la sua bocca gorgogliava di frasi immense, che senza tregua ne uscivano come serpenti». Durante l’arringa, che si conclude con una condanna a morte, Tarrou ha occhi soltanto per l’imputato: un misero, goffo ometto sulla trentina. E subito, istintivamente, solidarizza col condannato a morte, schierandosi dalla sua parte.
Tarrou abbandona la casa paterna e diventa militante di un partito (quello comunista, senza dubbio) che si batte per realizzare una società dove nessun uomo sarà più il nemico di altri uomini. Ma un giorno assiste a una fucilazione e si rende conto che anche nel partito si uccidono gli uomini. È per una “giusta causa”, gli viene detto. Ma anche suo padre si giustificava allo stesso modo. Ci sono sempre “ottime ragioni” per cancellare una vita… Decide allora di lasciare anche il partito perché non vuole più essere un “appestato” ossia qualcuno che dà la morte agli altri, che uccide o lascia uccidere, come suo padre magistrato che commina condanne a morte o i rivoluzionari che adottano gli stessi metodi nella convinzione (illusoria) di combattere quella logica mortifera.
È quanto confida a Rieux:
«Ho capito questo, che tutti eravamo nella peste; e ho perduto la pace. Ancor oggi la cerco, tentando di capirli tutti e di non essere il nemico mortale di nessuno. So soltanto che bisogna fare quello che occorre per non esser più un appestato, e che questo soltanto ci può far sperare nella pace o, al suo posto, in una buona morte. Questo può dar sollievo agli uomini e, se non salvarli, almeno fargli il minor male possibile e persino, talvolta, un po’ di bene. E per questo ho deciso di rifiutare tutto quello che, da vicino o da lontano, per buone o per cattive ragioni, faccia morire o giustifichi che si faccia morire. Per questo, inoltre, l’epidemia non m’insegna nulla, se non che bisogna combatterla al suo fianco, Rieux. Io so di scienza certa (tutto so della vita, lei lo vede bene) che ciascuno la porta in sé, la peste, e che nessuno, no, nessuno al mondo ne è immune. E che bisogna sorvegliarsi senza tregua per non essere spinti, in un minuto di distrazione, a respirare sulla faccia d’un altro e a trasmettergli il contagio».
Tarrou esprime così uno dei tanti simbolismi del racconto di Camus, il più profondo forse: la peste come male morale. Ben presto ha un’intuizione. Si accorge che anche all’infuori della politica, per la misteriosa solidarietà che lega gli uomini, non si può vivere senza far soffrire gli altri:
«Col tempo, mi sono semplicemente accorto che anche i migliori d’altri non potevano, oggi, fare a meno di uccidere o di lasciar uccidere: era nella logica in cui vivevano, e noi non possiamo fare un gesto in questo mondo senza correre il rischio di far morire. Sì, ho continuato ad aver vergogna, e ho capito questo, che tutti eravamo nella peste; e ho perduto la pace. Ancor oggi la cerco, tentando di capirli tutti e di non essere il nemico mortale di nessuno. So soltanto che bisogna fare quello che occorre per non esser più un appestato, e che questo soltanto ci può far sperare nella pace o, al suo posto, in una buona morte. Questo può dar sollievo agli uomini e, se non salvarli, almeno fargli il minor male possibile e persino, talvolta, un po’ di bene. E per questo ho deciso di rifiutare tutto quello che, da vicino o da lontano, per buone o per cattive ragioni, faccia morire o giustifichi che si faccia morire».
Tarrou sceglie di mettersi dalla parte delle vittime e partecipa alle formazioni sanitarie che cercano di opporsi al dilagare dell’epidemia, ma anch’egli, come Rieux e quel “santo impossibile” che fu Nietzsche, vuole diventare un santo senza credere in Dio. «Se si può essere un santo senza Dio», confessa al solito Rieux, «è il solo problema concreto che io oggi conosca».
Un proposito chiaro. Se non che Camus sembra aprirsi poi a qualcosa di superiore alla semplice solidarietà umana e al sentimento di giustizia. Ha compreso che l’uomo porta in sé una peste interiore che lo porta ad assassinare – spiritualmente prima, materialmente poi – i suoi fratelli in umanità. Ha intuito anche che alla legge del più forte che agisce solo per il proprio interesse occorre sostituire una legge d’amore disinteressata.
È quanto lascia intravedere la morte dello stesso Tarrou, piegato dalla peste proprio nel momento in cui l’epidemia sta per terminare e la popolazione di Orano si appresta a tornare al culto della felicità terrena.
Tarrou muore apparentemente da “santo” disperato: senza redenzione, con la morte che viene a segnare una brutale battuta d’arresto al suo progetto di “santità pelagiana” e lo lascia senza compimento.
Tuttavia al suo fianco, durante l’agonia, appare una presenza discreta, nascosta e quasi invisibile in tutto il racconto. È la madre del dottor Rieux, che veglia su di lui. Tempo addietro, prima di essere aggredito dal morbo, Tarrou era rimasto affascinato dalla dolcezza del suo volto, affermando che «uno sguardo in cui si leggeva tanta bontà sarebbe stato sempre più forte della peste».
La peste – Camus lo scrive a più riprese – è terrore, esilio e separazione. Porta la notte nei cuori. Come ogni male, divide gli uomini. Li consegna alla paura, privandoli degli affetti, lasciandoli soli davanti alla morte anche nell’estremo congedo. Una terrificante realtà che stiamo sperimentando anche noi in questi stessi giorni. Il racconto di Camus del resto è disseminato di scene che ci sono diventate tristemente familiari, a partire dalla soppressione dei riti funebri per i pazienti uccisi dal morbo.
Come può lo sguardo di un’anziana donna essere più forte della peste?
In una delle pagine più belle del romanzo, Tarrou contempla la signora Rieux mentre cala la notte e si avvicina la fine:
«Tarrou aveva la testa rivolta verso la signora Rieux; egli guardava la piccola ombra vicina a lui, raccolta s’una sedia, con le mani giunte sul grembo. E la contemplava con tale intensità che la signora Rieux si mise un dito sulle labbra e si alzò per spegnere la lampada notturna. Ma dietro le tende il giorno filtrava rapidamente, e poco dopo, quando i lineamenti del malato emersero dal buio, la signora Rieux poté vedere che lui la guardava sempre. Si chinò su di lui, gli aggiustò il capezzale e, rialzandosi, posò per un attimo la mano sui capelli bagnati e intorti. Sentì allora una voce fatta sorda, venuta da lontano, dirle grazie e che ora tutto andava bene. Quando fu di nuovo seduta, Tarrou aveva chiuso gli occhi, e il volto esaurito, nonostante la bocca sigillata, sembrava di nuovo sorridere».
Se non m’inganno qui Camus descrive proprio, attraverso gli umili gesti di attenzione di una madre terrena, un amore disinteressato che pacifica, rassicura, consola, accompagna, una luce notturna che suscita una impensabile gratitudine (la voce «venuta da lontano») nel momento stesso in cui ogni umana speranza è sul punto di svanire.
È difficile, per una coscienza cristiana, non vedere in questa immagine un’immagine della grazia, l’icona di un amore trascendente che tocca il cuore dell’uomo. Come pure è difficile non vedere nella madre la Madre. Come ha scritto Charles Moeller, «se nell’opera di Camus vi è una smagliatura, una ferita attraverso cui potrebbe penetrare il mistero della grazia andrebbe cercata proprio in queste pagine».
Eppure Camus stesso ha indicato La peste come la sua opera più anticristiana, nella quale l’uomo rimane deliberatamente sovrano di un mondo “autochiuso”, sordo a ogni ipotesi di un Dio trascendente. Ma la parola è essa stessa un mistero: a volte i passi in cui un autore sembra contraddire l’insieme della sua opera sono quelli in cui tradisce le sue più intime e inconfessate aspirazioni.